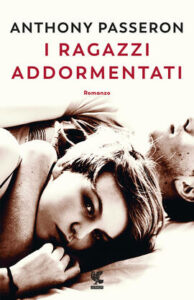Ogni volta che finisco di tradurre un libro, durante l’ultimissima rilettura, quella dei tocchi finali, penso stupita: Dai, pensavo peggio. Si legge bene. Scorre, a tratti è perfino brillante. Funziona.
Di solito, dopo quel momento di stupore, mi fermo a pensare, faccio mente locale e mi dico: Cosa ci sarà mai di strano, poi? In fondo, è il tuo lavoro. Ed è vero ma ci sono diversi ma.
Il primo ma è che io nasco francesista, divento francesista prestata all’inglese, e mi trasformo – in principio, mio malgrado; oggi con una certa soddisfazione – in anglista.
Il secondo ma è che ho ricominciato a tradurre narrativa relativamente da poco, dopo una pausa lunghissima, di anni, e se è vero che tradurre è come andare in bicicletta, quando non pedali da un po’, le prime volte che torni in sella fai fatica.
Il terzo ma è che ogni libro è, per forza di cose, una storia a sé, e se con alcuni ti senti fin da subito in sintonia, con altri invece percepisci una distanza siderale, e non è facile – e nemmeno rapido, almeno per me, e men che meno indolore – trovare la quadra, sgombrare la testa dai preconcetti, da preferenze e idiosincrasie puramente soggettive, e intonarsi a quella nuova voce che non solo non è la tua – prima o poi ci riuscirò a scrivere un post intitolato Voci che non sono la mia – ma non ci si avvicina neppure lontanamente.
In questi casi, nel caso dei libri con i quali percepiamo una distanza siderale, il processo somiglia molto all’inferno o al diavolo o alla morte – sì, mi sono intrippata coi tarocchi, per colpa di un’amica.
E c’è di più, ed è un pericolo subdolo che può avere conseguenze devastanti. Se io, poniamo il caso, mi sentissi particolarmente in sintonia con un certo tipo di scrittura, diciamo lineare, scarna, quasi minimalista, e mi trovassi a tradurre un libro con uno stile agli antipodi, diciamo baroccheggiante e ammiccante al limite del lezioso, non rischierei di fiutarci più baroccheggiamenti e ammiccamenti e leziosaggini di quante non ce ne siano in realtà, calcando troppo la mano, e compiendo uno scempio? Risposta: forse sì.
Ecco, è un po’ quello che mi è successo con l’ultimo libro che ho tradotto. Ho fatto una fatica enorme, come non mi capitava da tempo, a entrarci dentro, a riconoscerne il tono e l’intenzione, a capire in quale direzione dovevo muovermi, in quale registro dovevo andare a pescare parole ed espressioni. E mi chiedevo di continuo: starà esagerando davvero qui oppure sono io che ci vedo esagerazioni dove non ce ne sono?
In quei momenti, in quelle fasi, non c’è lucidità che tenga. O almeno, io non sono abbastanza razionale e assennata da dirmi: Dai, tranquilla, che in qualche modo, pure stavolta la porti a casa. No, io entro in un loop fatto di: Sono una capra, devo andare a zappare, ma perché ho accettato, oddio penseranno che faccio schifo e non lavorerò mai più. Probabilmente perché quando distribuivano il buonsenso e l’equilibrio, io ero assente.
E, invece, come dicevo all’inizio, durante l’ultimissima rilettura, mi è parso che funzionasse, mi è parso di essere riuscita non solo a dire quasi la stessa cosa, ma dirla anche quasi allo stesso modo – che è un dettaglio non proprio trascurabile, se traduciamo narrativa.
Ovviamente questa parentesi di beatitudine è di brevissima durata, perché una volta spedito il file, comincia un altro loop deleterio e snervante, fatto di: Oddio è se invece la traduzione è disastrosa, la revisione sarà una tragedia, penseranno che sono un’incapace e non lavorerò mai più.
Per fortuna, dopo la sacrosanta settimana di riposo e oblio tra un libro e l’altro, comincio a tradurre un romanzo con il quale mi sento del tutto in sintonia – ovviamente, questo lo dico ora; appena comincerò a lavorare partirà l’ennesimo loop. Forse, la vita – la mia vita, o almeno la mia vita lavorativa – è un pendolo destinato a oscillare in eterno tra sono una capra e devo andare a zappare.
DISCLAIMER: I miei post non hanno la presunzione di rivelare la verità assoluta. Sono solo riflessioni di una traduttrice tra tante. Dicono qualcosa del mio approccio a questo lavoro, che non è l’unico e – soprattutto – non è necessariamente quello migliore. Ma tant’è.