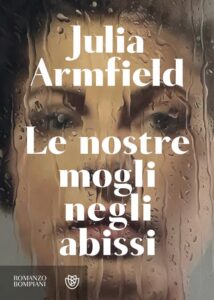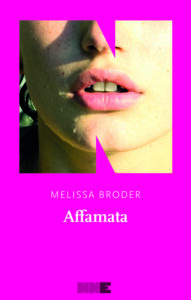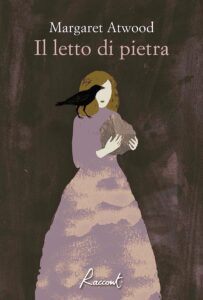Tradurre, per me, non è tanto dire (quasi) la stessa cosa – forse perché mi sembra scontato, al netto degli errori umani in cui inevitabilmente incappiamo tutti e da cui ci salvano i bravi revisori – quanto dirla (quasi) nello stesso modo.
Se è vero che tradurre è un processo lungo, stratificato – e a volte anche accidentato – è altrettanto vero che la traduzione comincia, almeno nel mio caso, nel momento in cui leggo il libro per la prima volta. È in quella fase che prendo le decisioni fondamentali, quelle che mi indicheranno la via lungo il cammino.
Quando ho letto La variabile Rachel, qualche mese prima di iniziare a lavorarci, mi è subito stato chiaro verso cosa avrei dovuto tendere: ritmo, scorrevolezza e dialoghi brillanti. Appena ho cominciato a tradurre, però, mi sono resa conto che dietro quel ritmo, dietro quella scorrevolezza e dietro quei dialoghi brillanti c’era anche dell’altro: una nota di fondo agrodolce a fare da contraltare, come in certe sitcom di una volta. E più andavo avanti, più quella nota di fondo agrodolce diventava prepotente.
La variabile Rachel è un romanzo di formazione, più esattamente un romanzo sui vent’anni. Quindi: sulle amicizie totalizzanti, gli amori turbolenti, le sbronze epiche, i sogni ambiziosi, le tormentose incertezze sul futuro.
Rachel ha avuto vent’anni a Cork, in Irlanda, nel 2010. Eppure sono piuttosto convinta che chiunque leggerà questo romanzo si immedesimerà in lei nonostante abbia avuto vent’anni in un altro luogo e in un altro decennio. Perché avere vent’anni è un’esperienza universale che, per certi versi, trascende lo spazio e il tempo.
Leggendo La variabile Rachel, forse ripenserete agli amici che avete perso di vista e a quelli che fanno ancora parte della vostra vita, a chi vi ha spezzato il cuore e a chi vi ha tenuto i capelli mentre vomitavate l’anima, ai concerti che erano vere e proprie esperienze mistiche, alle delusioni, ai tradimenti, alle risate irrefrenabili e ai pianti sotto al piumone, ai sogni che si sono realizzati o che magari, nel corso del tempo, sono cambiati o “si son trasformati in una professione adatta”.
Mentre traducevo La variabile Rachel, ve lo confesso, ho ripensato a tutte quelle cose, e mi sono anche aggrappata a certe sitcom che guardavo e a certi dischi che ascoltavo quando avevo l’età di Rachel, nel tentativo di riprodurre da un lato il ritmo, la scorrevolezza e i dialoghi brillanti, e dall’altro quella nota di fondo agrodolce che – me ne rendo conto adesso – è probabilmente l’autentica cifra stilistica del romanzo ma anche l’essenza dell’avere vent’anni, soprattutto se i tuoi vent’anni li ripercorri – come fa Rachel – a distanza di tempo, guardandoti indietro dopo aver raggiunto una nuova maturità, una diversa consapevolezza di te, degli altri e, in generale, del mondo.
Spero, come sempre, di essere riuscita a dire (quasi) la stessa cosa e soprattutto di essere riuscita a dirla (quasi) nello stesso modo.
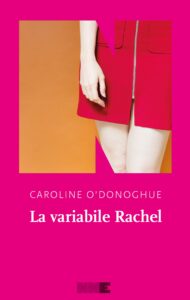
DISCLAIMER: I miei post non hanno la presunzione di rivelare la verità assoluta. Sono solo riflessioni di una traduttrice tra tante. Dicono qualcosa del mio approccio a questo lavoro, che non è l’unico e – soprattutto – non è necessariamente quello migliore. Ma tant’è.