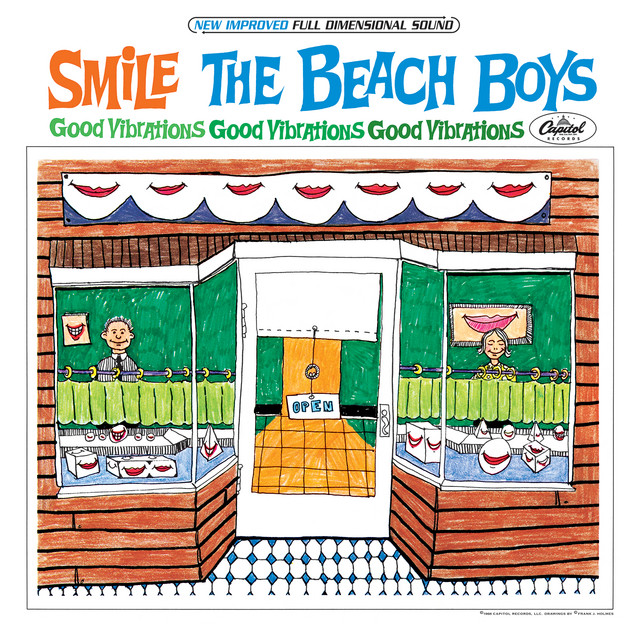Tradurre è anche – soprattutto? – rileggersi e limare, limare e ancora limare, alla ricerca di un ritmo, di un flusso.
Per ottenere quel ritmo, quel flusso, certe volte bisogna scendere a compromessi e sacrificare qualcosa, ma la traduzione è un continuo esercizio di equilibrio, un perenne gioco di pesi e contrappesi.
Volevo fare qualche esempio concreto, confrontando la prima stesura e quella finale, dopo quel lavoro – lavorio? – di limatura di cui dicevo prima.
Prima stesura: Aveva il cuore malandato, gli affari non erano mai andati peggio, era sull’orlo di un esaurimento nervoso.
Stesura finale: Aveva il cuore malconcio, gli affari non erano mai andati peggio, era sull’orlo di un esaurimento nervoso.
Malandato mi piace molto di più di malmesso, ma sono costretta a cambiarlo per evitare la ripetizione con andati.
Prima stesura: A volte, quando non aveva voglia di leggere, si metteva alla finestra a guardare la neve. Nelle serate ventose, si precipitava giù dalle montagne avvolte dalle tenebre, volteggiava nel bagliore bianco-azzurro del diner e nel riflesso rosa dell’insegna al neon, per poi scomparire tra i boschi, nel buio, dall’altra parte della strada.
Stesura finale: Di tanto in tanto, quando non aveva voglia di leggere, si metteva alla finestra a guardare la neve. Nelle serate ventose, si precipitava giù dalle montagne avvolte dalle tenebre, turbinava nel bagliore bianco-azzurro del diner e nel riflesso rosa dell’insegna al neon, per poi scomparire tra i boschi, nel buio, dall’altra parte della strada.
Anche qui, per evitare delle assonanze che suonerebbero male e forse perfino malissimo, devo intervenire: decido quale delle tre parole problematiche voglio assolutamente mantenere/salvare (avvolte) e poi valuto le opzioni (posso trasformare a volte in di tanto in tanto e volteggiava in turbinava? direi di sì).
Prima stesura: Si sedeva con atteggiamento solenne e meditabondo, poi si toglieva il cappello, lo poggiava sul bancone e infine, con garbo, chiedeva un caffè. Aveva i baffi imperlati di ghiaccio. Henry gli serviva il caffè e una fetta di torta di mele e rimaneva dietro al bancone mentre l’uomo beveva il caffè corretto col whisky. A volte, dopo che Kuzitski aveva mandato giù il secondo caffè, Henry si metteva a parlare del suo cuore.
Stesura finale: Si sedeva con atteggiamento solenne e meditabondo, poi si toglieva il cappello, lo poggiava sul bancone e infine, con garbo, chiedeva un caffè. Aveva i baffi imperlati di ghiaccio. Henry gli serviva anche una fetta di torta di mele e rimaneva dietro al bancone mentre l’uomo beveva il caffè corretto col whisky. A volte, dopo che Kuzitski aveva mandato giù la seconda tazza, Henry si metteva a parlare del suo cuore.
Qua ci sono banalmente troppi caffè – in inglese non dà fastidio, in italiano sì. Perciò bisogna capire come aggirare l’ostacolo. Per esempio, se scrivo gli serviva anche una fetta di torta, presumo si capisca che gli serve la fetta di torta e il caffè. Allo stesso modo, poco dopo, posso scrivere che manda giù la seconda tazza, tanto lo sappiamo cosa sta bevendo.
Prima stesura: La gente commentava quella vena di violenza che balenava in Henry Soames (pur compatendolo, aveva qualcosa di inquietante) osservando che, col senno di poi, non era venuta fuori dal nulla.
Stesura finale: La gente commentava quella vena di violenza che balenava in Henry Soames (pur compatendolo, aveva qualcosa di inquietante) osservando che, col senno di poi, c’erano già state delle avvisaglie.
Qui la questione è un po’ diversa, non si tratta di ripetizioni o di assonanze, ma di naturalezza. Nel primo caso, la traduzione è molto letterale, ma non funziona, nessuno scriverebbe una cosa del genere in italiano. Inizialmente avevo pensato a qualcosa tipo: non era un fulmine a ciel sereno, ma mi sembrava troppo carica e idiomatica in quel contesto, tanto più che l’inglese è assolutamente piano, per cui ho optato per c’erano già state delle avvisaglie.
Certo, è un lavoro lungo, a tratti anche noioso e perfino frustrante, ma è necessario, soprattutto su un testo come questo, che non pone chissà quali difficoltà né in termini di comprensione né di resa linguistica. Ed è un lavoro che può fare la differenza perché il confine tra un testo pulito, semplice e un testo scialbo, sciatto è molto sottile.
DISCLAIMER: I miei post non hanno la presunzione di rivelare la verità assoluta. Sono solo riflessioni di una traduttrice tra tante. Dicono qualcosa del mio approccio a questo lavoro, che non è l’unico e – soprattutto – non è necessariamente quello migliore. Ma tant’è.